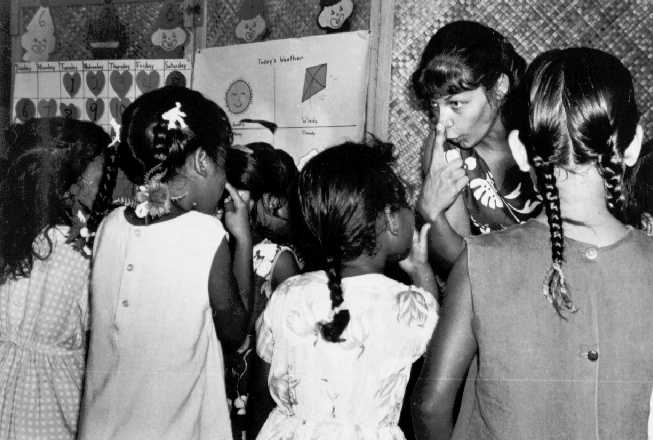Era il gennaio del 2024 quando comparve un corsivo di Ernesto Galli Della Loggia contro la presenza degli alunni con disabilità nelle classi comuni (qui la toppa, una settimana dopo, peggio del buco). Potevamo pensare che fosse il solito editoriale provocatorio di una persona ormai nota per le sue posizioni reazionarie (ma che intanto è entrata nella commissione per la riscrittura delle indicazioni nazionali e ha fatto pesare il suo contributo).
Poi succede che, circa un anno dopo, compaia un interessante lavoro dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani (OCPI da ora), firmato da Carlo Cottarelli e Gianmaria Olmastroni, sul tema dell’inclusione scolastica. E leggendolo capisci di trovarti di fronte ad un disegno ben preciso. Ma andiamo con ordine.
La scuola più inclusiva d’Europa
Partiamo da un dato: l’articolo certifica che il nostro è il sistema più inclusivo d’Europa: oltre il 97% degli studenti con disabilità in Italia trascorre, infatti, almeno l’80% del proprio tempo (soglia fissata dall’UNESCO per definire una persona inclusa) con altri studenti nelle classi e scuole comuni. In altri paesi, gli studenti con disabilità sono in scuole o classi speciali per una parte più o meno grande del loro tempo. Ciò nonostante l’Italia continui a spendere per l’istruzione solo il 4% (dato del 2023), meno della media UE del 4,8%.
La scuola più precaria d’Europa
Il rapporto passa poi a evidenziare i tre problemi principali dell’inclusione italiana, che condividiamo in pieno:
- precariato (6 insegnanti di sostegno, IDS, su 10 con contratto a termine)
- mancanza di specializzazione (3 IDS su 10 senza titolo specifico per il sostegno)
- mancanza di continuità didattica (è raro che un alunno con disabilità sia seguito da uno stesso IDS per un intero ciclo scolastico)
Il rapporto mette anche in evidenza un dato di fatto: la causa originaria di questi problemi è l’assenza di stabilizzazione (l’Italia è stata messa di recente in mora dalla Commissione Europea proprio per abuso di contratti a termine nella scuola) e le procedure concorsuali confuse, contraddittorie, in continuo mutamento. Il problema della mancanza di specializzazione, infatti, non riguarda gli insegnanti a tempo indeterminato, che per legge devono avere, oltre ad una laurea, un titolo di specializzazione; se si procedesse a stabilizzare tutti, il problema non si porrebbe più. Anche la mancanza di continuità didattica è conseguenza, oltre che della precarietà, anche del fatto che, in un paese dove le procedure concorsuali cambiano ogni volta e i posti messi a bando sono sempre insufficienti rispetto al fabbisogno reale, il sostegno diventa naturalmente e inevitabilmente un canale d’accesso all’insegnamento disciplinare.
NB: Valditara sa benissimo quali sono i problemi di questo modello, ma pensa di risolverli con modi che mantengano in piedi lo status quo, quindi niente stabilizzazione, formazione bignami erogata dall’INDIRE e continuità didattica su richiesta delle famiglie (subordinando così l’insegnante alla valutazione della famiglia/consumatrice).
Un modello davvero efficace?
Gli autori presentano infine i dati (fonte Eurostat) relativi ai cosiddetti Early School Leavers (ESL), cioè i 18-24enni al 2022 che si sono fermati al primo ciclo d’istruzione (livello ISCED 2, per l’Italia la terza media). La percentuale di alunni con disabilità lieve o grave fermatisi al primo ciclo è, in Italia, il 29,5%, contro, scrive l’OCPI, il 22,5% medio dell’UE.
Qui si svela, finalmente, il piano politico dell’articolo: uno stacco di 7 punti è uno smacco per il sistema più inclusivo d’Europa, tanto più se la percentuale degli ESL con disabilità è simile a quella della Germania (29,6%) che però ha un sistema scolastico dove solo il 52% circa degli alunni con disabilità è considerabile incluso. Quindi, concludono gli autori, il sistema va cambiato, forse: in che direzione? Facile: tagliare la spesa, quindi il numero di insegnanti, così automaticamente diventano più stabili e specializzati. Insomma, la ricetta classica del neoliberismo, che tanto bene ha portato all’Italia e all’Europa.
Un uso allegro delle statistiche
Peccato che nella foga di arrivare all’originalissima proposta dei tagli, gli autori abbiano omesso di riportare un dato importante: quello, cioè, degli ESL totali in Italia e in UE, sia con disabilità che senza. La percentuale in questo caso scende, così pure la differenza tra Italia e UE (11,5% contro 9,6%), ma l’Italia mantiene, pur lievemente, un livello maggiore di abbandoni rispetto alla media. Inclusione vuol dire far rientrare un alunno con bisogni educativi speciali – che siano derivanti da disabilità o da altri gap – all’interno del sistema generale, e se questo ha di per sé problemi di abbandono (non dimentichiamo che fino a pochi anni fa il tasso in Italia era del 17,8%) questi purtroppo si riverberano, accentuati, sugli alunni delle categorie di cui sopra.
Per capire, alla luce di questo, quale sarebbe la percentuale di ESL con disabilità attesa in Italia, è sufficiente una semplice proporzione (ESL totali UE : ESL con disabilità UE = ESL totali Italia : ?): la cifra che viene fuori è 26,9%, e ci indica che tasso di abbandono dovremmo aspettarci in Italia in rapporto al sistema generale. La differenza col tasso effettivo si riduce a 2,6 punti percentuali: per noi è comunque grave e inaccettabile, ma non è il distacco enorme presentato dall’articolo.
Il problema e le (vere) soluzioni
Un sistema scolastico che, ancora oggi, lascia per strada oltre uno studente su 10 prima dei 18 anni, e addirittura quasi uno studente con disabilità su 3, è un sistema che non funziona e che va corretto, ma la ricetta non è quella degli autori dell’articolo (né potevamo aspettarci diversamente): occorre portare la spesa per istruzione sul PIL almeno alla media europea (o al livello dei paesi più grandi, se davvero vogliamo migliorare); stabilizzare tuto il personale scolastico, docente e non docente, unica strada per garantire professionalizzazione e continuità; per gli studenti con disabilità occorre inoltre aumentare di numero e garantire gli assistenti materiali e alla comunicazione, la cui presenza oggi dipende dagli enti locali e quindi è estremamente differente da nord a sud; occorre lavorare al miglioramento del trasporto pubblico locale e scolastico e dell’accessibilità degli edifici, specie per gli alunni con disabilità fisiche e motorie. E non abbiamo minimamente toccato il tema dell’assistenza sanitaria per gli alunni con disabilità, che in una metà del paese, complici i tagli e la riforma del Titolo V della Costituzione, è diventata una chimera. Studenti con disabilità che non possono seguire alcun tipo di terapia se non pagandola sono destinati ad abbandonare anche col doppio degli IDS. Insomma, servono soldi, nell’istruzione, nella sanità, agli enti locali, certo non tagli. Prendendo in considerazione tutti gli elementi che contribuiscono al successo formativo di un alunno con disabilità, potremmo, ribaltando le conclusioni dell’articolo, scrivere che è quasi un miracolo che, a fronte di tutte queste carenze e disfunzioni, gli ESL con disabilità si fermino a meno del 30%!
Ma purtroppo viviamo in una realtà capovolta, dove si racconta il contrario della verità con l’obiettivo dichiarato, in questo caso, di distruggere quel poco di buono che resta tra le istituzioni del nostro Stato.
Il ping pong dei distruttori della scuola pubblica
Non è un caso che, a pochi giorni dalla pubblicazione, l’articolo dell’OCPI sia stato ripreso e citato su Il Foglio in un editoriale che andava nella stessa direzione, anzi peggio: riprendendo le parti peggiori dell’articolo (che, lo ribadiamo, è complessivamente molto utile, al netto delle conclusioni), l’autore discetta della presunta funzione di ammortizzatore sociale delle assunzioni (sempre precarie, ricordiamolo) di IDS maggiori al Sud (lievemente) piuttosto che al Nord, e ha addirittura la sfacciataggine di citare Gramsci per parlare di “meridionalizzazione dello Stato”. Un articolo grondante razzismo e stupidità – come se gli USR meridionali potessero valutare e decidere sulla base di considerazioni di tipo socio-economico – che non a caso porta la firma di Sabino Cassese, l’autore della famigerata Autonomia Differenziata che costituisce la fine dello stato unitario come l’abbiamo conosciuto.
Insomma, siamo di fronte ad un vero e proprio attacco, concertato, organizzato e perseguito con metodo da parte delle classi dominanti e dei loro intellettuali nei confronti di una delle ultime istituzioni democratiche e progressiste del paese, che resiste, nonostante tutto. L’attacco non cesserà per magia: sta a noi prenderne consapevolezza e organizzarci per ribaltare il tavolo.
Leggi anche:
- Il nostro commento al primo editoriale di Ernesto Galli Della Loggia
- la nostra lettura della riforma della didattica della Storia firmata da Galli Della Loggia e Valditara
- il nostro commento alla riforma della specializzazione per il sostegno voluta da Valditara