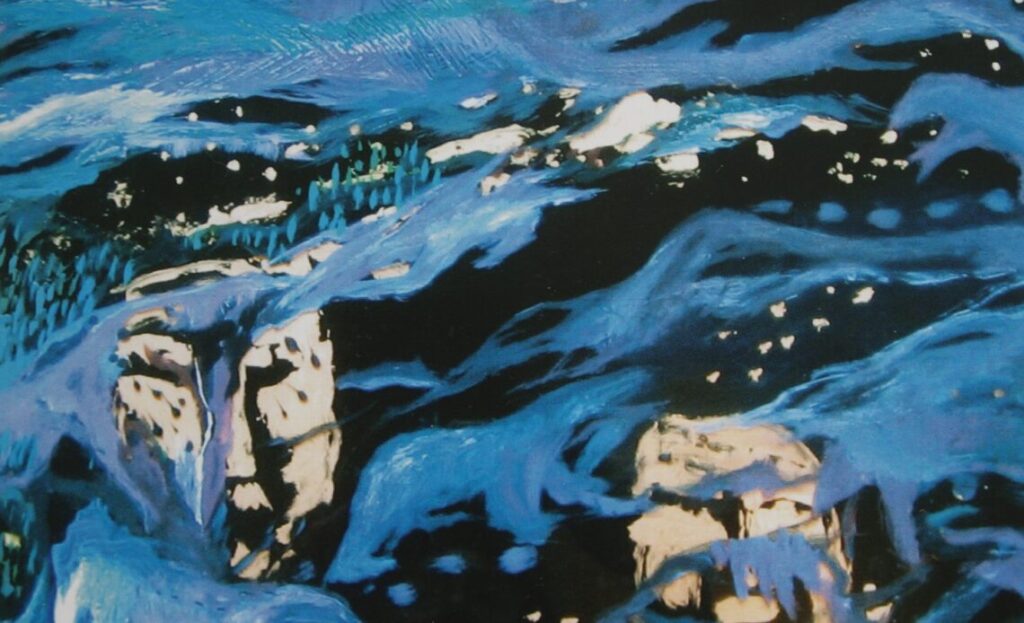In una città che vorrebbe definirsi “moderna”, i parchi pubblici dovrebbero essere spazi vitali: luoghi di libertà, di gioco, di aggregazione, di respiro per le comunità.
Invece, allo stato attuale, numerosi spazi verdi di Napoli sono inaccessibili o versano in condizione di grave degrado:
- L’accordo per la riapertura del parco Urbano dei Camaldoli (135 ettari, un polmone della città) è stato firmato nel 2022, ma ad oggi il parco è ancora chiuso e versa in condizioni di totale abbandono;
- Il parco San Gennaro e il parco Emilia Laudati sono ancora chiusi, nonostante le dichiarazioni dell’Assessore al verde del Comune di Napoli che, dopo infiniti rinvii, aveva promesso la riapertura il 15 ottobre.
Gli altri parchi segnalano aperture discontinue, manutenzioni rimandate, ambienti rovinati, percorsi non curati, aree completamente abbandonate. Il risultato è che vaste zone verdi che dovrebbero essere fruibili diventano zone fantasma o zone chiuse.
Parallelamente, l’amministrazione comunale apre le porte a società private per la gestione di aree verdi e parchi. Per fare un esempio, la guardiania del parco Re Ladislao è stata affidata alla Cosmopol S.p.a., società di vigilanza che nel 2023 è stata posta in amministrazione giudiziaria in seguito ad un’inchiesta per caporalato che ha evidenziato lo sfruttamento di lavoratori pagati meno di 5 euro all’ora.
Se questa è la ditta cui la pubblica amministrazione affida appaldi per la “gestione” del verde pubblico, viene naturale chiedersi: che modello di qualità, di trasparenza, di cura del bene comune può assicurare?
Il problema non riguarda soltanto casi isolati ma rientra in un disegno più ampio, già annunciato da tempo ma che ormai è sotto gli occhi tutti.
L’amministrazione della città di Napoli sta portando avanti una politica di privatizzazione del verde e dei parchi urbani, così come indicato nella bozza del regolamento sul verde: l’articolo 31 prevede, infatti, il ricorso «forme di partenariato pubblico-privato e contratti di concessione per la realizzazione e/o la gestione e manutenzione di aree verdi comunali», offrendo al gestore privato la possibilità di realizzare “eventi per la cittadinanza, anche a pagamento”.
In sostanza: un diritto collettivo (il diritto al verde, all’aria, al gioco, alla socialità) che dovrebbe essere tutelato come bene comune viene trasformato in una merce, in un asset da “gestire”, da “sfruttare”, da “mettere a reddito”.
Questo processo di privatizzazione apre la strada a parchi “premiati” se gestiti come business (come dimostra l’esempio del parco di Capodimonte), mentre i parchi che non producono reddito vengono penalizzati, creando ulteriori discriminazioni tra i quartieri (chi può pagare / chi non può) e minando alla base l’obiettivo di garantire all’intera popolazione la stessa possibilità di accedere alle aree verdi.
Noi siamo contrari a questo modello di gestione degli spazi verdi e rivendichiamo:
- La riapertura dei parchi oggi chiusi (Camaldoli, San Gennaro, Emilia Laudati, ecc.) in maniera trasparente, fornendo informazioni certe sulle tempistiche e le risorse dedicate;
- La reinternalizzazione della gestione dei parchi, la previsione di controlli effetti e garanzie occupazionali per i lavoratori coinvolti;
- La revisione del regolamento sul verde per escludere la possibilità di introdurre “aree a pagamento” o “attività commerciali”;
- La partecipazione attiva delle comunità locali, dei comitati cittadini, promuovendo forme di autogestione degli spazi, affinché l’accesso sia considerato un diritto e non un privilegio.
Se i parchi sono spazio di libertà e il verde è un elemento di democrazia urbana, quello che oggi accade a Napoli non è semplice cattiva amministrazione: è una scelta politica. E quella scelta politica va contrastata!
Il patto presentato a metà ottobre 2025 – l’“Agenda Napoli” – dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e il candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, segna un passaggio cruciale: dietro la retorica della “sinergia tra Comune e Regione”, si intende estendere il modello napoletano basato sulla gestione privatistica all’intero territorio campano, trasformando un esperimento fallimentare in un paradigma da applicare a livello regionale
Le ricadute di questa impostazione sarebbero profonde e durature:
- Snaturamento del concetto di bene comune: il verde non rappresenterebbe più un diritto universale, ma una risorsa da “valorizzare” economicamente.
- Uniformazione verso il basso: i comuni campani, spesso in dissesto finanziario, verrebbero spinti ad affidare la gestione del verde ai privati per mancanza di risorse.
- Marginalizzazione delle aree interne: i territori rurali e i piccoli centri, privi di interesse commerciale, resterebbero esclusi dagli investimenti, accentuando lo squilibrio tra città e provincia.
- Rischio ambientale: la logica del profitto spinge alla trasformazione dei parchi in spazi “eventificati”, con strutture temporanee, pavimentazioni, parcheggi, riducendo la biodiversità e il valore ecologico delle aree verdi.
- Attacco ai diritti dei lavoratori: la gestione privatizzata comporta appalti esterni, precarizzazione dei lavoratori e perdita di competenze interne nei servizi comunali e regionali.
Di fatto, se il modello Napoli diventa “modello Campania”, la politica del verde pubblico rischia di essere sostituita da una politica del verde commerciale: i parchi diventano “location”, i giardini “format”, il diritto alla natura un “servizio a domanda individuale”.
Questo accordo segna quindi una linea politica precisa: dove c’era pubblico, ci sarà partenariato; dove c’era diritto, ci sarà concessione; dove c’era cittadinanza, ci sarà consumo.