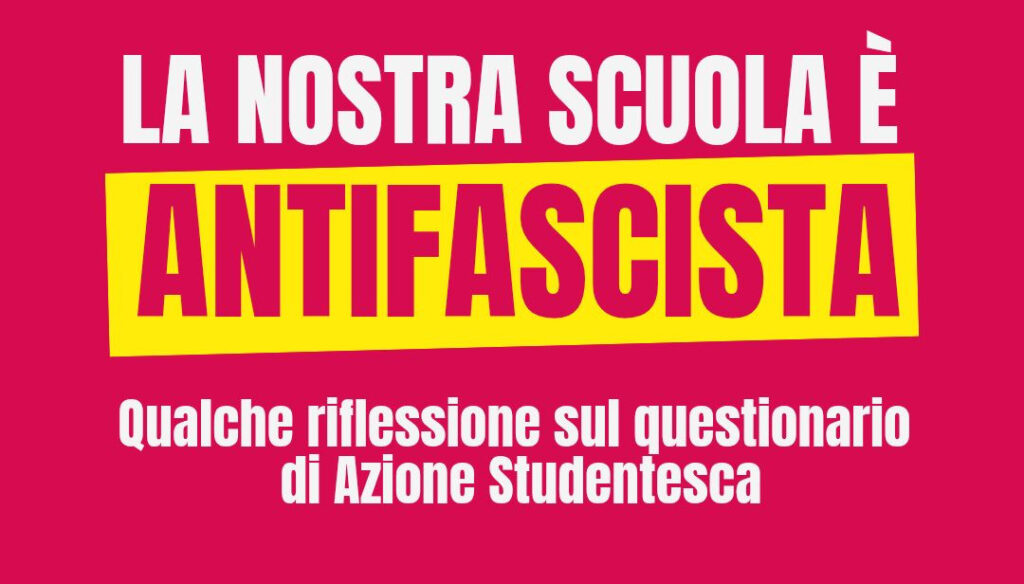Nelle ultime settimane, l’attenzione internazionale si è senza dubbio concentrata sull’escalation tra India e Pakistan, di cui parleremo più approfonditamente una volta che la situazione si sarà calmata. Sebbene nessuno dei due eserciti abbia attraversato il confine o la linea di controllo, la preoccupazione è comunque comprensibile: entrambi i Paesi dispongono di armi nucleari. Ora si è tornati di fatto al cessate il fuoco del 1948, che è rimasto in vigore nei decenni successivi senza un vero e proprio accordo di pace. L’attenzione internazionale è rimasta giustamente concentrata anche sul genocidio in Palestina, con lo Stato di Israele che ha rafforzato l’assedio totale su Gaza, forse per vendicare il ritorno delle persone palestinesi nel nord di Gaza il 27 gennaio 2025, una vera e propria sfida alla guerra genocida.
Nel frattempo, alcuni conflitti, come la guerra in corso in Sudan, sono stati quasi completamente dimenticati. Questo è il tema centrale di questa newsletter, realizzata attraverso conversazioni con operatrici e operatori umanitari e personalità politiche sudanesi. Come confermato nel nostro reportage, l’argomentazione secondo cui questa guerra è sconcertante e non ha spiegazioni facili è un riflesso del razzismo dominante che definisce i conflitti nel continente africano come inspiegabili e interminabili. Ovviamente ogni guerra ha delle cause precise e quindi esistono anche modi per provi fine. Bisogna mettere da parte il linguaggio del sangue che ha attanagliato il nostro mondo e trovare invece i dettagli politici in cui risiede la possibilità di pace.
 Due anni fa, la fragile ma promettente pace in Sudan è stata infranta quando le Forze Armate Sudanesi (SAF) e le Forze di Supporto Rapido (RSF) – entrambe bracci armati dello Stato sudanese – sono entrate in guerra tra loro. Il secondo anniversario di questa guerra è stato commemorato l’11 aprile 2025 con un terribile attacco delle RSF al campo profughi di Zamzam, nel Darfur settentrionale. Come ha raccontato Hawa, madre di tre figli sopravvissuta all’attacco, “le bombe cadevano sull’ospedale […] Noi sopravvissuti siamo scappati con solo i nostri bambini sulle spalle”.
Due anni fa, la fragile ma promettente pace in Sudan è stata infranta quando le Forze Armate Sudanesi (SAF) e le Forze di Supporto Rapido (RSF) – entrambe bracci armati dello Stato sudanese – sono entrate in guerra tra loro. Il secondo anniversario di questa guerra è stato commemorato l’11 aprile 2025 con un terribile attacco delle RSF al campo profughi di Zamzam, nel Darfur settentrionale. Come ha raccontato Hawa, madre di tre figli sopravvissuta all’attacco, “le bombe cadevano sull’ospedale […] Noi sopravvissuti siamo scappati con solo i nostri bambini sulle spalle”.
Il 16 aprile il campo, che un tempo ospitava mezzo milione di rifugiati, era distrutto, con centinaia di persone morte e gli altre costrette a fuggire nelle vicine El Fasher e Tawila. In due anni di combattimenti, almeno 150.000 persone sono state uccise e quasi 13 milioni – oltre un quinto della popolazione sudanese di 51 milioni – sono state sfollate. Questa catastrofe in corso appare del tutto insensata alla maggior parte delle persone sudanesi.
Tutto sembrava diverso l’11 aprile 2019, sei anni prima del massacro di Zamzam, quando il presidente di lunga data Omar al-Bashir è stato deposto da un movimento popolare e, alla fine, dall’esercito. Le proteste contro il governo di al-Bashir sono iniziate nel dicembre 2018 a causa dell’inflazione e di una crisi sociale sempre più accentuata. Incapace di rispondere alle richieste del popolo, al-Bashir non è riuscito a mantenere il potere, nemmeno con la forza, soprattutto quando l’esercito sudanese si è rivoltato contro di lui (come l’esercito egiziano aveva fatto contro il presidente Hosni Mubarak nel 2011). Al-Bashir è stato rovesciato da quello che in seguito è diventato noto come Consiglio militare di transizione, guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhan con l’assistenza del tenente generale Mohamed “Hemedti” Hamdan Dagalo.
 I gruppi che organizzavano le proteste sociali hanno formato una coalizione chiamata Forze per la Libertà e il Cambiamento (FFC). La FFC comprendeva il Partito Comunista Sudanese, le Forze di Consenso Nazionale, l’Associazione Professionale Sudanese, il Fronte Rivoluzionario Sudanese, le Donne dei Gruppi Civici e Politici Sudanesi e tanti altri comitati di resistenza o di quartiere. Sotto la pressione delle proteste guidate dalla FFC, a metà del 2019 l’esercito ha firmato un accordo per supervisionare la transizione verso un governo civile.
I gruppi che organizzavano le proteste sociali hanno formato una coalizione chiamata Forze per la Libertà e il Cambiamento (FFC). La FFC comprendeva il Partito Comunista Sudanese, le Forze di Consenso Nazionale, l’Associazione Professionale Sudanese, il Fronte Rivoluzionario Sudanese, le Donne dei Gruppi Civici e Politici Sudanesi e tanti altri comitati di resistenza o di quartiere. Sotto la pressione delle proteste guidate dalla FFC, a metà del 2019 l’esercito ha firmato un accordo per supervisionare la transizione verso un governo civile.
Con l’assistenza dell’Unione Africana è stato istituito il Consiglio di sovranità transitoria composto da cinque membri militari e sei civili. Il consiglio ha nominato Abdalla Hamdok (nato nel 1956) come nuovo Primo ministro e Nemat Abdullah Khair (nato nel 1957) come Presidente della Corte suprema. Hamdok, un diplomatico molto riservato che aveva svolto un lavoro molto importante presso la Commissione economica per l’Africa, sembrava adatto al ruolo di Primo ministro di transizione. Khair, giudice di lunga data che aveva aderito ai movimenti di protesta contro al-Bashir, aveva trovato il tono giusto come capo competente della magistratura. La porta verso un nuovo futuro sembrava aprirsi per il Sudan.
 Ma ben presto il Sudan è caduto preda delle pressioni della propria storia. Nel 2021, dopo diversi colpi di Stato falliti, il generale Abdel Fattah al-Burhan ha preso il potere, con l’argomento di “difendere la transizione”, ma in realtà per riportare al potere gli uomini di al-Bashir che erano stati messi da parte. Le rivoluzioni sono spesso interrotte dal ritorno del vecchio regime, la cui presa sulle forze armate e sulla società non è mai così facile da scrollarsi di dosso. I due militari – al-Burhan e Hemedti – sapevano che qualsiasi azione di giustizia contro il governo di al-Bashir li avrebbe colpiti duramente, poiché erano stati il braccio armato del suo regime (le forze di Hemedti, conosciute colloquialmente come Janja’wid – o “diavoli a cavallo” – erano state implicate in violazioni dei diritti umani durante la campagna di al-Bashir in Darfur). Altrettanto importante è il fatto che i due uomini e la loro cerchia avevano interessi materiali in gioco, tra cui il controllo delle miniere d’oro sudanesi nel Darfur e nel Kordofan.
Ma ben presto il Sudan è caduto preda delle pressioni della propria storia. Nel 2021, dopo diversi colpi di Stato falliti, il generale Abdel Fattah al-Burhan ha preso il potere, con l’argomento di “difendere la transizione”, ma in realtà per riportare al potere gli uomini di al-Bashir che erano stati messi da parte. Le rivoluzioni sono spesso interrotte dal ritorno del vecchio regime, la cui presa sulle forze armate e sulla società non è mai così facile da scrollarsi di dosso. I due militari – al-Burhan e Hemedti – sapevano che qualsiasi azione di giustizia contro il governo di al-Bashir li avrebbe colpiti duramente, poiché erano stati il braccio armato del suo regime (le forze di Hemedti, conosciute colloquialmente come Janja’wid – o “diavoli a cavallo” – erano state implicate in violazioni dei diritti umani durante la campagna di al-Bashir in Darfur). Altrettanto importante è il fatto che i due uomini e la loro cerchia avevano interessi materiali in gioco, tra cui il controllo delle miniere d’oro sudanesi nel Darfur e nel Kordofan.
Con uomini come questi, la paura della “gabbia sospesa” e la fame di maggiori ricompense sono fondamentali. Un vero trasferimento di potere richiede una rottura completa con la vecchia società, difficile da realizzare a meno che l’esercito non crolli o venga completamente ricostruito secondo l’immagine della nuova società piuttosto che con gli elementi di quella vecchia. Sia al-Burhan che Hemedti si sono opposti a questa transizione e, con una rapida repressione dei movimenti di massa, in particolare dei sindacati e dei comunisti, si sono assicurati il potere a Khartoum.
 Quando una banda di criminale forma un “gruppo per” qualsiasi paese, tutto il popolo dovrebbe preoccuparsi. Nel 2021, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno formato il “QUAD per il Sudan” con il presunto scopo, secondo quanto annunciato, di riportare il Paese alla democrazia. Il Sudan si trovava sul filo del rasoio degli intrighi geopolitici quando cominciarono a circolare accuse secondo cui l’esercito controrivoluzionario sudanese aveva iniziato a sviluppare stretti rapporti con la Russia. Nel 2019, al-Bashir discusse un accordo che avrebbe permesso alla Russia di costruire una base navale sul Mar Rosso, che avrebbe dato al Paese un punto d’appoggio nel continente africano. La caduta di al-Bashir ha messo a repentaglio la costruzione di questa, possibilità riaperta quando la sua vecchia squadra è tornata al potere. Questo ha portato il Sudan nel mirino del crescente conflitto tra l’Occidente e la Russia, nonché tra le monarchie arabe del Golfo.
Quando una banda di criminale forma un “gruppo per” qualsiasi paese, tutto il popolo dovrebbe preoccuparsi. Nel 2021, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno formato il “QUAD per il Sudan” con il presunto scopo, secondo quanto annunciato, di riportare il Paese alla democrazia. Il Sudan si trovava sul filo del rasoio degli intrighi geopolitici quando cominciarono a circolare accuse secondo cui l’esercito controrivoluzionario sudanese aveva iniziato a sviluppare stretti rapporti con la Russia. Nel 2019, al-Bashir discusse un accordo che avrebbe permesso alla Russia di costruire una base navale sul Mar Rosso, che avrebbe dato al Paese un punto d’appoggio nel continente africano. La caduta di al-Bashir ha messo a repentaglio la costruzione di questa, possibilità riaperta quando la sua vecchia squadra è tornata al potere. Questo ha portato il Sudan nel mirino del crescente conflitto tra l’Occidente e la Russia, nonché tra le monarchie arabe del Golfo.
Quando un Paese viene coinvolto nei conflitti di altri Paesi, i propri problemi diventano difficili da discernere. All’interno della cricca al potere composta dai militari e dai resti del gruppo di al-Bashir, ha cominciato a crescere il dissenso sull’integrazione delle forze armate e sulla spartizione del bottino. In apparenza, sembrava che si discutesse sui tempi del ritorno al governo civile, ma in realtà la disputa riguardava il potere militare e il controllo delle risorse.
 Queste lotte di potere interne sono infine sfociate nella guerra civile del 2023, uno scontro inevitabile che ha tutte le caratteristiche di una guerra per procura, con le SAF sostenute dall’Egitto e dall’Arabia Saudita, le RSF sostenute dagli Emirati Arabi Uniti e altri attori esterni che tirano le fila dietro le quinte. I colloqui continuano qua e là, ma non stanno facendo alcun progresso. La guerra sembra avere una sua logica, con i 300.000 soldati delle SAF incapaci di ottenere risultati significativi contro i 100.000 soldati altamente motivati delle RSF. Le risorse infinite provenienti dalla vendita dell’oro e dal sostegno esterno potrebbero far durare questa guerra all’infinito – o almeno fino a quando il mondo non la dimenticherà (come le guerre dimenticate nella Repubblica Democratica del Congo e lungo i confini del Myanmar).
Queste lotte di potere interne sono infine sfociate nella guerra civile del 2023, uno scontro inevitabile che ha tutte le caratteristiche di una guerra per procura, con le SAF sostenute dall’Egitto e dall’Arabia Saudita, le RSF sostenute dagli Emirati Arabi Uniti e altri attori esterni che tirano le fila dietro le quinte. I colloqui continuano qua e là, ma non stanno facendo alcun progresso. La guerra sembra avere una sua logica, con i 300.000 soldati delle SAF incapaci di ottenere risultati significativi contro i 100.000 soldati altamente motivati delle RSF. Le risorse infinite provenienti dalla vendita dell’oro e dal sostegno esterno potrebbero far durare questa guerra all’infinito – o almeno fino a quando il mondo non la dimenticherà (come le guerre dimenticate nella Repubblica Democratica del Congo e lungo i confini del Myanmar).
Le Nazioni Unite continuano a rilasciare dichiarazioni mentre varie organizzazioni per i diritti umani chiedono di esercitare ulteriori pressioni sia sulle SAF che sulle RSF. Ma non è successo nulla. Anche i colloqui di pace sono divisi: gli emirati e gli egiziani ne stanno mediando alcuni al Cairo, mentre i sauditi ne hanno organizzati altri a Gedda e gli inglesi hanno deciso di crearne altri ancora a Londra. Non è chiaro chi stia parlando con chi e di cosa.
 Il tentativo più attivo di mediare un accordo di pace è venuto dall’Unione Africana (UA) nel gennaio 2024 con la creazione del Gruppo di alto livello per il Sudan (HLP-Sudan). Il panel è presieduto dal dottor Mohamed Ibn Chambas, diplomatico ghanese che è stato rappresentante speciale dell’Unione Africana e delle Nazioni Unite per il Darfur e capo dell’Operazione ibrida AU-ONU in Darfur (UNAMID) dal 2012 al 2014. Conosce entrambi i generali ed è consapevole della complessità della situazione in Sudan. Gli altri due membri del gruppo sono la dottoressa Specioza Wandira-Kazibwe, ex vicepresidente dell’Uganda, e l’ambasciatore Francisco Madeira del Mozambico, ex rappresentante speciale dell’UA in Somalia e capo della missione dell’UA in quel paese. L’HLP-Sudan sta collaborando con l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), l’organismo regionale dell’Africa orientale, per portare le due parti al tavolo dei negoziati per un accordo di cessate il fuoco e, in ultima analisi, per un accordo di pace definitivo.
Il tentativo più attivo di mediare un accordo di pace è venuto dall’Unione Africana (UA) nel gennaio 2024 con la creazione del Gruppo di alto livello per il Sudan (HLP-Sudan). Il panel è presieduto dal dottor Mohamed Ibn Chambas, diplomatico ghanese che è stato rappresentante speciale dell’Unione Africana e delle Nazioni Unite per il Darfur e capo dell’Operazione ibrida AU-ONU in Darfur (UNAMID) dal 2012 al 2014. Conosce entrambi i generali ed è consapevole della complessità della situazione in Sudan. Gli altri due membri del gruppo sono la dottoressa Specioza Wandira-Kazibwe, ex vicepresidente dell’Uganda, e l’ambasciatore Francisco Madeira del Mozambico, ex rappresentante speciale dell’UA in Somalia e capo della missione dell’UA in quel paese. L’HLP-Sudan sta collaborando con l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), l’organismo regionale dell’Africa orientale, per portare le due parti al tavolo dei negoziati per un accordo di cessate il fuoco e, in ultima analisi, per un accordo di pace definitivo.
È importante sottolineare che l’HLP-Sudan ha incontrato una serie di persone provenienti da tutto lo spettro politico del Paese, compresi membri di partiti politici, militari e gruppi della società civile. Molti di loro erano firmatari dell’Accordo di pace di Juba del 2020, che includeva anche le fazioni in guerra del Darfur, del Kordofan meridionale e del Nilo Azzurro. Ma i negoziatori devono affrontare un problema tra le fasce civili. Nell’ottobre 2023, il primo ministro destituito Abdalla Hamdok ha formato la coalizione Taqaddum (Progresso), che ha portato le voci della società civile al tavolo dei negoziati. Tuttavia, nel corso degli ultimi due anni, sono emerse divisioni tra i sostenitori dell’una o dell’altra fazione, tanto che nel febbraio 2025 la coalizione si è sciolta. Hamdok ha quindi formato un nuovo gruppo, Sumoud (Resilienza), che vuole mantenere una posizione equidistante da entrambe le parti. A marzo, al-Hadi Idris, ex membro del Consiglio di sovranità transitoria, ha formato la coalizione Ta’sis (Fondazione Sudan), che ha poi nominato Hemedti dell’RSF come suo leader. Anche i gruppi civili si sono effettivamente divisi lungo le linee della guerra civile.
 L’anno scorso ho parlato con Hamdok, che sembrava esausto per la lunga guerra e l’inutilità dei negoziati. Da diplomatico impassibile, Hamdok riteneva che le guerre possano logorare gli eserciti e costringerli a negoziare. Conosce bene la sua storia: il Sudan ha ottenuto l’indipendenza dalla Gran Bretagna e dall’Egitto nel 1956, ma poi è entrato nella sua prima guerra civile tra il nord e il sud, terminata con l’accordo di Addis Abeba del 1972; il decennio di pace che è seguito (favorito dai proventi del petrolio del sud) è ormai un lontano ricordo; una seconda guerra civile tra nord e sud si è combattuta dal 1983 al 2005, che ha portato al referendum del 2011 e alla divisione del Paese in Sudan e Sud Sudan; infine, un terribile conflitto nel Darfur è iniziato nel 2003 e si è lentamente concluso nel 2010, portando alla fine al rovesciamento di Omar al-Bashir nel 2019. All’epoca, lo slogan contro al-Bashir era tisqut bas (cadi). E lui è caduto. Ma il terreno continua a tremare.
L’anno scorso ho parlato con Hamdok, che sembrava esausto per la lunga guerra e l’inutilità dei negoziati. Da diplomatico impassibile, Hamdok riteneva che le guerre possano logorare gli eserciti e costringerli a negoziare. Conosce bene la sua storia: il Sudan ha ottenuto l’indipendenza dalla Gran Bretagna e dall’Egitto nel 1956, ma poi è entrato nella sua prima guerra civile tra il nord e il sud, terminata con l’accordo di Addis Abeba del 1972; il decennio di pace che è seguito (favorito dai proventi del petrolio del sud) è ormai un lontano ricordo; una seconda guerra civile tra nord e sud si è combattuta dal 1983 al 2005, che ha portato al referendum del 2011 e alla divisione del Paese in Sudan e Sud Sudan; infine, un terribile conflitto nel Darfur è iniziato nel 2003 e si è lentamente concluso nel 2010, portando alla fine al rovesciamento di Omar al-Bashir nel 2019. All’epoca, lo slogan contro al-Bashir era tisqut bas (cadi). E lui è caduto. Ma il terreno continua a tremare.
Il popolo sudanese non vede la pace da generazioni. La speranza di Hamdok è una speranza contro la storia, ma per un futuro.
Con affetto,
Vijay
*Traduzione della ventesima newsletter (2025) di Tricontinental: Institute for Social Research.
Come Potere al Popolo traduciamo la newsletter prodotta da Tricontinental: Institute for Social Research perché pensiamo affronti temi spesso dimenticati da media e organizzazioni nostrane e perché offre sempre un punto di vista interessante e inusuale per ciò che si legge solitamente in Italia. Questo non significa che le opinioni espresse rispecchino necessariamente le posizioni di Potere al Popolo. A volte accade, altre volte no. Ma crediamo sia comunque importante offrire un punto di vista che spesso manca nel panorama italiano.