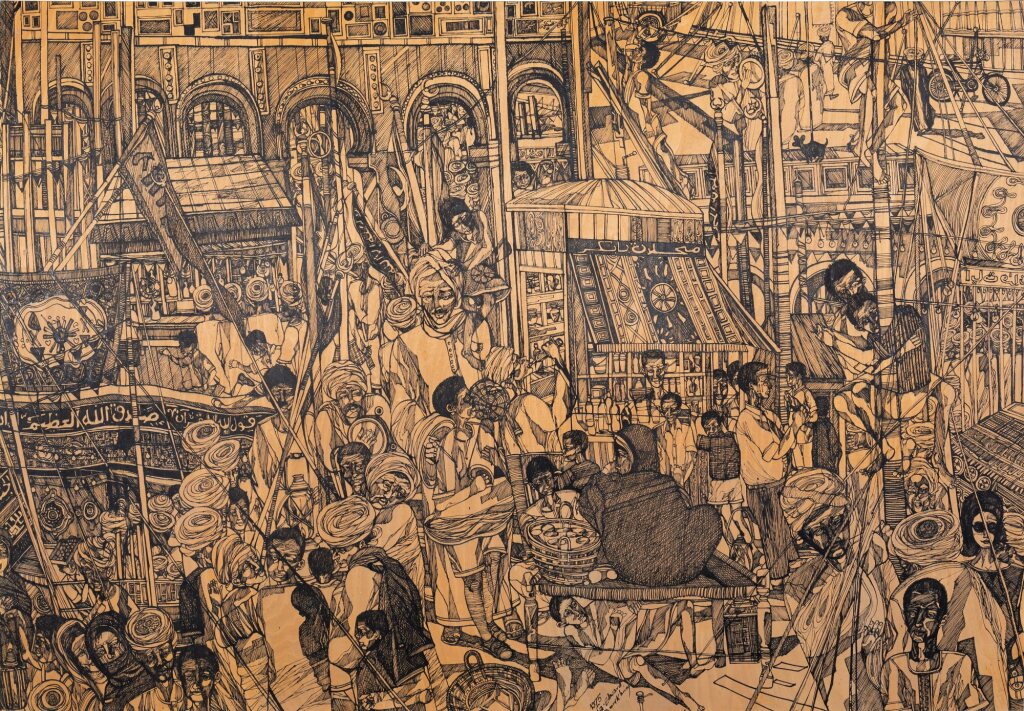Ai primi di novembre, il Segretario Generale delle Nazioni Unite (ONU) António Guterres ha parlato della “terribile crisi in Sudan, che sta sfuggendo ad ogni controllo”. Ha esortato le parti in conflitto a “porre fine a questo incubo di violenza – ora”. Esiste un modo per porre fine alla guerra, ma semplicemente non c’è la volontà politica di farlo. Nel maggio del 2025 abbiamo scritto della storia del conflitto. Nel 2019 abbiamo parlato della rivolta sociale che ha avuto luogo quell’anno e delle sue conseguenze. Oggi come Tricontinental: Institute for Social Research, Assemblea Internazionale dei Popoli e Pan Africanism Today pubblichiamo l’allerta rossa n. 21 sulla necessità della pace in Sudan.
 Qual è la realtà sul campo in Sudan?
Qual è la realtà sul campo in Sudan?
Il 15 aprile 2023 è scoppiata la guerra tra le Forze Armate Sudanesi (Sudanese Armed Forces SAF) guidate dal capo del Consiglio Militare di Transizione, il generale Abdel Fattah al-Burhan e le Forze di Supporto Rapido (Rapid Support Forces RSF) guidate dal tenente generale Mohamed “Hemedti” Hamdan Dagalo. Da allora, sostenute da vari governi esterni al Sudan, le due parti hanno combattuto una terribile guerra di logoramento in cui le vittime principali sono i civili. È impossibile dire quante persone siano morte, ma è chiaro che il bilancio delle vittime è significativo. Secondo una stima, solo nei giorni tra aprile 2023 e giugno 2024 il numero delle vittime è stato pari a 150.000; inoltre, diversi crimini contro l’umanità commessi da entrambe le parti sono già stati documentati da varie organizzazioni per i diritti umani. Almeno 14,5 milioni di sudanesi su una popolazione di 51 milioni sono stati sfollati. Le persone che vivono nella fascia tra El Fasher, nel Darfur settentrionale, e Kadugli, nel Kordofan meridionale, stanno lottando contro la fame acuta e la carestia. Una recente analisi della Classificazione integrata della sicurezza alimentare delle Nazioni Unite (scala IPC) ha rilevato che circa 21,2 milioni di sudanesi, pari al 45% della popolazione, sono esposti a livelli elevati di grave insicurezza alimentare, con 375.000 persone in tutto il paese che soffrono di fame a livelli “catastrofici” (cioè sull’orlo della morte per inedia).
Dall’inizio della guerra, centinaia di migliaia di sfollati interni hanno cercato rifugio a El Fasher, allora controllata in gran parte dalle SAF. Circa 260.000 civili erano ancora lì nell’ottobre 2025, quando le RSF hanno spezzato la resistenza, sono entrate in città e hanno compiuto una serie di massacri documentati. Tra le vittime c’erano 460 pazienti e i loro accompagnatori del Saudi Maternity Hospital. La caduta della città ha fatto sì che le RSF controllino ora gran parte della vasta provincia del Darfur, mentre le SAF controllano gran parte del Sudan orientale, compreso Port Sudan, l’accesso del Paese al mare e al commercio internazionale, nonché la capitale Khartoum.
Al momento non vi sono segni di de-escalation.
 Perché le SAF e le RSF stanno combattendo?
Perché le SAF e le RSF stanno combattendo?
Nessuna guerra di questa portata ha una causa semplice. La ragione politica è chiara: si tratta di una controrivoluzione contro la rivolta popolare del 2019 che è riuscita a rovesciare il presidente Omar al-Bashir, al potere dal 1993 e i cui ultimi anni di governo sono stati caratterizzati da un aumento dell’inflazione e da una crisi sociale.
Le forze popolari e di sinistra che hanno guidato la rivolta del 2019 – il Partito Comunista Sudanese, le Forze di Consenso Nazionale, l’Associazione Professionale Sudanese, il Fronte Rivoluzionario Sudanese, le Donne dei Gruppi Civici e Politici Sudanesi e molti comitati di resistenza locali e di quartiere – hanno costretto i militari ad accettare di supervisionare la transizione verso un governo civile. Con l’assistenza dell’Unione Africana, è stato istituito il Consiglio di sovranità transitorio, composto da cinque membri militari e sei civili. Abdalla Hamdok è stato nominato primo ministro e il giudice Nemat Abdullah Khair presidente della Corte Suprema, con al-Burhan e Hemedti anch’essi membri del consiglio. Il governo civico-militare ha ulteriormente distrutto l’economia lasciando fluttuare la valuta e privatizzando lo Stato, rendendo così più redditizio il contrabbando di oro e rafforzando le RSF (questo governo ha anche firmato gli Accordi di Abraham, che hanno normalizzato le relazioni con Israele). Le politiche del governo civico-militare hanno esacerbato le condizioni fino ad arrivare alla perdita di controllo dello Stato di sicurezza (potere) e del commercio dell’oro (ricchezza).
Nonostante i loro ruoli nel consiglio, al-Burhan e Hemedti hanno tentato dei colpi di Stato fino a quando non ci sono riusciti nel 2021. Dopo aver messo da parte i civili, i due leader militari si sono scontrati tra loro. Gli ufficiali delle SAF hanno cercato di mantenere il controllo sull’apparato statale, che nel 2019 ha assorbito l’82% delle risorse di bilancio dello Stato (come confermato dal primo ministro Abdalla Hamdok nel 2020). Hanno inoltre cercato di mantenere il controllo delle sue imprese, gestendo più di 200 società attraverso entità come il Defence Industries System controllato dalle SAF (le entrate annuali sono stimate a 2 miliardi di dollari) e conquistando una quota significativa dell’economia formale del Sudan nei settori minerario, delle telecomunicazioni e del commercio di materie prime di import-export. Le RSF – provenienti dalla milizia Janja’wid (diavoli a cavallo) – hanno cercato di sfruttare l’economia di guerra attorno alla Al Junaid Multi-Activities Corporation, che controlla le principali aree di produzione dell’oro nel Darfur e circa una mezza dozzina di siti minerari, tra cui Jebel Amer. Poiché il 50-80% della produzione totale di oro del Sudan è contrabbandato (numeri del 2022) principalmente verso gli Emirati Arabi Uniti e poiché le RSF dominano la produzione nelle zone minerarie artigianali del Sudan occidentale (che rappresentano l’80-85% della produzione totale), le RSF incassano ogni anno ingenti somme provenienti dai proventi dell’oro (stimati a 860 milioni di dollari nel 2024 solo per le miniere del Darfur).
Al di là di queste contese politiche e materiali, vi sono pressioni ecologiche che aggravano la crisi. Una delle ragioni del lungo conflitto nel Darfur è stata l’inaridimento del Sahel. Per decenni, le piogge irregolari e le ondate di calore dovute alla catastrofe climatica hanno ampliato il deserto del Sahara verso sud, rendendo le risorse idriche una causa di conflitto e scatenando scontri tra nomadi e agricoltori stanziali. Metà della popolazione sudanese vive in condizioni di grave insicurezza alimentare. L’incapacità di creare un piano economico per una popolazione devastata dai rapidi cambiamenti climatici, insieme al furto di risorse da parte di una piccola élite, rende il Sudan vulnerabile a conflitti di lunga durata. Non si tratta solo di una guerra tra due personalità forti, ma di una lotta per la trasformazione delle risorse e il loro saccheggio da parte di potenze esterne. Un accordo di cessate il fuoco è nuovamente sul tavolo, ma la probabilità che venga accettato o rispettato è molto bassa fintanto che le risorse rimangono il premio ambito dai vari gruppi armati.
 Quali sono le possibilità di pace in Sudan?
Quali sono le possibilità di pace in Sudan?
Il percorso verso la pace in Sudan richiederebbe sei elementi:
1. Un cessate il fuoco immediato e monitorato che includa la creazione di corridoi umanitari per il transito di cibo e medicine. Questi corridoi dovrebbero essere gestiti dai Comitati di Resistenza, che hanno la credibilità democratica e le reti per fornire aiuti direttamente a chi ne ha bisogno.
2. La fine dell’economia di guerra, in particolare la chiusura dei canali di approvvigionamento di oro e armi. Ciò comporterebbe l’imposizione di sanzioni severe sulla vendita di armi e sull’acquisto di oro dagli Emirati Arabi Uniti fino a quando questi non interromperanno ogni relazione con le RSF. È inoltre necessario attuare controlli sulle esportazioni a Port Sudan.
3. Il ritorno in sicurezza degli esiliati politici e l’avvio di un processo di ricostruzione delle istituzioni politiche sotto un governo civile eletto o sostenuto dalle forze popolari, principalmente dai Comitati di Resistenza. Le SAF devono essere private del loro potere politico e dei loro beni economici e sottomesse al governo. Le RSF devono essere disarmate e smobilitate.
4. La ricostruzione immediata dell’alta magistratura sudanese per indagare e perseguire i responsabili delle atrocità.
5. La creazione immediata di un processo che identifichi le responsabilità, incluso il perseguimento dei signori della guerra attraverso un tribunale adeguato costituito in Sudan.
6. La ricostruzione immediata della commissione di pianificazione del Sudan e del suo ministero delle finanze per trasferire le ricchezze verso i beni pubblici e le protezioni sociali e non dedicarle semplicemente all’export.
Questi sei punti seguono i tre pilastri dell’Unione Africana e dell’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo AU-IGAD Joint Roadmap for the Resolution of the Conflict in Sudan (2023). La difficoltà di questa roadmap, come di proposte simili, è che dipende dai donatori, compresi gli attori implicati nella violenza. Per realizzare questi sei punti è necessario esercitare pressioni sulle potenze esterne affinché cessino il loro sostegno alle SAF e alle RSF. Tra queste figurano l’Egitto, l’Unione Europea, il Qatar, la Russia, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti. Né questa roadmap ufficiale né il canale di Jeddah – un percorso di mediazione saudita-statunitense avviato nel 2023 che si concentra esclusivamente su brevi tregue militari e l’entrata di aiuti umanitari – includono i gruppi civili sudanesi, tanto meno i Comitati di Resistenza.
 Il Sudan ha prodotto i suoi propri poeti che cantano il dolore e la sofferenza, ma abbiamo deciso di chiudere con una nota diversa. Nel 1961, il poeta comunista Taj el-Sir el-Hassan (1935-2013) scrisse “Una canzone afro-asiatica”, che inizia commemorando il massacro di Kosti a Joudeh nel 1956, quando 194 contadini in sciopero furono soffocati a morte mentre erano in custodia della polizia. Ma è alla fine della canzone che ci rivolgiamo, con la voce del poeta che risuona sopra gli spari:
Il Sudan ha prodotto i suoi propri poeti che cantano il dolore e la sofferenza, ma abbiamo deciso di chiudere con una nota diversa. Nel 1961, il poeta comunista Taj el-Sir el-Hassan (1935-2013) scrisse “Una canzone afro-asiatica”, che inizia commemorando il massacro di Kosti a Joudeh nel 1956, quando 194 contadini in sciopero furono soffocati a morte mentre erano in custodia della polizia. Ma è alla fine della canzone che ci rivolgiamo, con la voce del poeta che risuona sopra gli spari:
Nel cuore dell’Africa sto in prima linea,
e fino a Bandung il mio cielo si sta espandendo.
L’olivo è la mia ombra e il mio cortile,
O miei compagni:
O compagni d’avanguardia, che guidate il mio popolo alla gloria,
le vostre candele stanno inondando il mio cuore di luce verde.
Canterò la strofa finale,
alla mia amata terra;
ai miei compagni in Asia;
alla Malesia,
e alla vivace Bandung.
Al popolo di El Fasher, a quelli di Khartoum, ai miei compagni a Port Sudan: camminate verso la pace.
Con affetto,
Vijay
*Traduzione della quarantaseiesima newsletter (2025) di Tricontinental: Institute for Social Research.
Come Potere al Popolo traduciamo la newsletter prodotta da Tricontinental: Institute for Social Research perché pensiamo affronti temi spesso dimenticati da media e organizzazioni nostrane e perché offre sempre un punto di vista interessante e inusuale per ciò che si legge solitamente in Italia. Questo non significa che le opinioni espresse rispecchino necessariamente le posizioni di Potere al Popolo. A volte accade, altre volte no. Ma crediamo sia comunque importante offrire un punto di vista che spesso manca nel panorama italiano.